la vita di Giovanni Battista Montini,
le sue origini culturali, il rapporto con Roncalli.
Il pontificato all’insegna della duplice fedeltà
alla Tradizione e agli appelli del mondo moderno
di Giancarlo Zizola

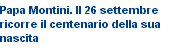
| Paolo VI Nel centenario della nascita |
«Il nostro nome
è Pietro»
| Un famoso vaticanista ripercorre la vita di Giovanni Battista Montini, le sue origini culturali, il rapporto con Roncalli. Il pontificato all’insegna della duplice fedeltà alla Tradizione e agli appelli del mondo moderno di Giancarlo Zizola |
 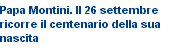 |
Le
iniziative scientifiche dell’Istituto Paolo VI di Brescia e le ricerche storiche
collaterali hanno favorito, coi più profondi scavi archivistici, un approccio più
fondato e preciso alla complessità della figura di Paolo VI, di cui la ricorrenza del
centenario della nascita (in Concesio, il 26 settembre 1897) offre l’opportunità
d’una rilettura e, insieme, di una ricapitolazione, si spera affrancata dalle
controversie emotive.
Un
criterio emergente e consolidato nella storiografia montiniana è quello del cattolicesimo
democratico, simmetrico all’altra categoria sintetica, del riformismo prudente, ove
la prudenza, per riprendere un detto del cardinale Siri, «in taluni casi consiglia
l’audacia, esclude solo la temerarietà». Figlio di un giornalista divenuto deputato
del Partito popolare di don Sturzo, Giovanni Battista Montini si è nutrito giovanissimo
del lievito di un cattolicesimo riconciliato con la democrazia. È divenuto in questo
solco assistente della Fuci all’epoca del conflitto col fascismo, ha tradotto I tre
riformatori di Jacques Maritain, ha fatto da ponte in Segreteria di Stato tra il Papa e
gli elementi più dinamici dell’intellighenzia cattolica europea, finché Pio XII,
cedendo alle pressioni del "Partito Romano", fu indotto a esiliarlo arcivescovo
di Milano.
|
Che la decisione papale di privarsi del suo sostituto fosse in organica relazione con l’offensiva prodotta dal Partito Romano agli inizi del 1954, la documentazione già nota lo attesta al di là di ogni ragionevole dubbio. L’appunto vergato da padre Riccardo Lombardi circa le intenzioni di quel gruppo di riuscire a «togliere i poteri a Montini per la politica italiana e darli a Tardini (Fanfani fa capo a Montini)» ha comprovato sufficientemente la genesi di un’operazione politico-ecclesiale, mirata a osteggiare l’apertura a sinistra, considerata un cedimento nell’ordine dei principi alle forze marxiste nel governo dell’Italia, anche a prezzo dell’autonomia politica dei cattolici militanti nella Democrazia cristiana (cfr. Giancarlo Zizola, Il microfono di Dio, Pio XII, padre Lombardi e i cattolici italiani, Milano 1990, pp. 348ss.). In questo ambito l’estromissione di Montini dalla Segreteria di Stato, pubblicata il 3 novembre 1954, rappresentava l’apogeo di un riordinamento complessivo che nella primavera aveva richiesto le dimissioni del presidente della Giac Mario Rossi e la sostituzione fin dal 1952, l’anno dell’operazione Sturzo per le elezioni amministrative a Roma, di Vittorino Veronese con Luigi Gedda nella carica di presidente generale dell’Azione cattolica italiana. |
Quanto
alla cultura riformatrice di Montini, può ben valere, oltre agli abbondanti dati offerti
dalle ricerche, la confidenza da lui fatta nel 1950 precisamente a padre Lombardi circa la
necessità di una radicale riforma spirituale del papato: «Privati del potere temporale i
Papi ne han mantenuto solo le forme esteriori, come l’unico aspetto che potevano
serbare. Fatta la Conciliazione, quelle forme sono rimaste. Ma devono cadere e un Papa un
giorno attaccherà quel mantello […]. Che il Papa lasci il Vaticano e tutti lì, coi
loro stipendi, e se ne vada, almeno alcuni periodi, in San Giovanni in Laterano: a vivere
coi suoi seminaristi, col suo popolo, con un altro rituale nuovo… Torni in Vaticano
solo ogni tanto. E in San Giovanni inizi il nuovo governo della Chiesa, come il povero
Pietro…» (ibidem, p.232).
Non era
perciò accidentale che Montini fosse, insieme a Giacomo Lercaro, il solo vescovo italiano
a proporre per il Concilio un programma non mediocre di riforme, come attestano gli Atti
ante-preparatori del Vaticano II e la Storia del Vaticano II, nel primo volume dedicato
appunto alla genesi prossima e remota dell’assise convocata da Giovanni XXIII (cfr.
AA.VV., Storia del Concilio Vaticano II, I, Peekers, Leuven, Società editrice Il Mulino,
Bologna 1995).
| Né potrebbero essere ricondotti al solo aspetto dell’amicizia personale, per quanto così ricca e significativa, i legami privilegiati intrattenuti da Giovanni XXIII, fin dai tempi del suo patriarcato veneziano e anche prima, con monsignor Montini: resta da approfondire il contenuto del colloquio del 15 agosto 1955 tra Roncalli e Montini, fresco arcivescovo di Milano, nella casa del primo a Sotto il Monte. La lapide murata a Cà Martino, in memoria dell’incontro, informa che essi «intrecciarono un presago colloquio sui destini della Chiesa». Erano riuniti in quell’ora misteriosa i due futuri papi. E certo, come Giovanni XXIII seppe inventare rapidamente, dopo l’elezione, i modi di una reintegrazione piena dell’esule nello spazio simbolico del governo supremo, facendolo primo dei suoi cardinali e affidandogli ruoli determinanti nella gestione e riprogrammazione |  |
del Concilio, così l’arcivescovo di Milano si ritrovò naturalmente ad assumere
nelle proprie mani un’eredità che non pochi avrebbero voluto vedere smantellata al
più presto: un’eredità per cui lo stesso Montini si era battuto, che consisteva
nell’agire in modo che la Chiesa si rivolgesse a tutti gli uomini, al di sopra di
tutti i muri e tutte le barriere, senza confondere la causa dell’Evangelo con quella
di una coalizione, sia pure di popoli liberi, senza cercare il rimedio fuori della Chiesa,
nelle alleanze politiche, ma nel più profondo della sua tradizione, nella sua propria
riforma e nel suo ringiovanimento, abbattendo gli ostacoli tra i diversi ovili del Cristo
e prodigandosi a servire «l’uomo in quanto tale, e non solo i cattolici, a difendere
ovunque e anzitutto i diritti della persona umana, e non solo quelli della Chiesa
cattolica», secondo le parole testamentarie di papa Giovanni.
Toccava
dunque a Montini, per queste antiche solidarietà, il compito di dare un quadro strategico
e una realizzazione graduale e consensuale alla brusca svolta giovannea, evitando rischi
di rottura. Di qui le linee principali di pontificato che il conclave del 1963 incoraggia
ad assumere ma entro un argine giustificato dalle tensioni stesse che ne segnarono
l’esito: riprendere e svolgere il Concilio in un quadro papale (senza eccessi
rivoluzionari già criticati da Montini nell’introduzione ai Tre riformatori),
riforma prudente delle istituzioni ecclesiastiche, a cominciare dalla Curia romana,
sviluppo del dialogo ecumenico, ricerca di nuovi rapporti tra Chiesa e società moderna,
cercando ogni strumento utile alla preservazione e al consolidamento della società
cristiana assediata dalla secolarizzazione.
 |
L’enciclica programmatica Ecclesiam suam (1964) disegnava la missione
della Chiesa secondo i tre cerchi del dialogo comunitario interno, ecumenico con le Chiese
sorelle, pastorale e culturale con il mondo moderno. Nel suo programma il Papa assumeva nel quadro istituzionale l’eredità della "primavera" giovannea e, nello stesso tempo, gli orientamenti, all’epoca ancora incoativi, del Vaticano II. Lo ha ben chiarito il padre Giacomo Martina: «Montini probabilmente non avrebbe aperto il Concilio, ma in quel momento appariva l’uomo più idoneo per concluderlo […]. Era considerato come l’espressione più autorevole del pensiero di Giovanni XXIII e, insieme, come l’uomo capace di realizzare con audacia ma con maggior ordine e metodo gli ideali del Papa appena scomparso» (cfr. G. Martina, Storia della Chiesa, da Lutero ai nostri giorni, IV L’età contemporanea, Brescia 1995, p.318). Il contributo di Paolo VI al Concilio è stato oggetto di valutazioni differenti. La priorità da lui accordata alla dimensione giuridico-istituzionale, del resto necessaria per rendere impegnative le innovazioni conciliari, gli è stata contestata per i sacrifici che avrebbe richiesto – al di là del necessario – alla dimensione kerigmatica e profetica. |
Egli diede risalto alla funzione primaziale del papato nella dinamica del Concilio
controllandone i lavori e intervenendo più volte, sia per riservare a sé tematiche
cruciali (il celibato sacerdotale, il controllo delle nascite, la riforma della Curia),
sia per arbitrare i rapporti fra maggioranza e minoranza mediante rettifiche di alcuni
schemi in senso riduttivo, allo scopo di favorire l’assorbimento del dissenso e
conclusioni il più possibile consensuali.
Con il
motu proprio Integrae servandae del dicembre 1965, vigilia della chiusura del Concilio,
egli procedette alla riforma del Sant’Offizio, che fu dotato cinque anni dopo di una
ratio agendi più rispettosa del diritto degli accusati alla difesa. La sua opera di
riforma dell’apparato centrale era ispirata dalla convinzione, espressa in un
discorso del 14 luglio 1965, che «bisogna approfondire l’idea dell’autorità
della Chiesa, purificarla da forme che non le sono essenziali (anche se in date
circostanze le sono state legittime, come il potere temporale, ad esempio) e ricondurla al
suo originario e cristiano criterio». Di qui la creazione di una serie di organismi
nuovi, quali il Consilium de laicis, la commissione Iustitia et Pax, i Segretariati per i
non cristiani e per i non credenti, che si collocano accanto al Segretariato per
l’Unione dei cristiani, mediante il quale papa Giovanni aveva rotto nel 1960 il
monopolio del Sant’Offizio e incardinato l’ecumenismo nel cuore del governo
centrale della Chiesa romana. Tra il 1965 e il 1968 il Vaticano di Paolo VI appariva un
cantiere fervoroso di riforme, sostenute da un’intensa opera educativa svolta in
prima persona dal Papa per far assimilare il Concilio all’intero "popolo di
Dio", al di là delle forti resistenze di un nucleo ostile nella Curia romana. Il 15
agosto 1967 la riforma generale della Curia, decretata dalla costituzione Regimini
Ecclesiae Universae, introdusse importanti modifiche strutturali (rifiuto del carrierismo,
limiti di età e temporalità delle cariche, divieto del cumulo delle funzioni, decadenza
dei responsabili supremi alla morte del papa, ruolo direttivo della Segreteria di Stato
sul lavoro dei dicasteri, soprattutto il recupero di un’immagine più spirituale e
pastorale del servizio). L’introduzione dei limiti di età obbligava personaggi
potenti della vecchia Curia, come Tisserant, Ottaviani e Pizzardo, ad uscire di scena. Per
la prima volta alla testa dei dicasteri centrali le responsabilità venivano affidate a
dei pastori provenienti dalle Chiese locali di vari continenti.
| Lo stesso segretario di Stato di Paolo VI, dopo la scomparsa del cardinale
Amleto Cicognani, era un non diplomatico, l’ex segretario dell’episcopato
francese Jean Villot, mentre il controllo dell’apparato veniva affidato a Giovanni
Benelli, un giovane prelato di cui il Papa dovette privarsi nel 1977, inviandolo cardinale
a Firenze, cedendo alle pressioni di una Curia che non aveva gradito il metodo intrusivo. Pezzo per pezzo scomparve la forma sacrale e regale in cui il papato si era avvolto. La rinuncia alla tiara sull’altare del Concilio introdusse una serie di modernizzazioni esteriori, come il congedo delle guardie nobili, la semplificazione della corte pontificia, lo scioglimento dei corpi armati pontifici, la stessa riforma della diplomazia vaticana, confermata come struttura per essere tuttavia ricondotta – secondo uno stile tipicamente montiniano – a funzioni ecclesiali, di servizio alla comunione tra il papato e le Chiese locali. |
|
Lo stesso potere cardinalizio venne intaccato con il motu proprio Ingravescentem
aetatem (21 novembre 1970) col quale si aboliva il diritto dei cardinali che avessero
compiuto ottant’anni di partecipare all’elezione del papa. Con la costituzione
Romano pontifici eligendo (1° ottobre 1975) Montini fissò in 120 cardinali il tetto del
corpo elettorale. L’internazionalizzazione del collegio cardinalizio sotto Paolo VI
fu di tale portata da intaccare l’egemonia tradizionale degli italiani e degli
europei sul conclave: alla fine del pontificato, i cardinali elettori non europei
risultarono tanto numerosi quanto i cardinali europei, con 12 africani, 9 asiatici, 21
latinoamericani, 3 dell’area del Pacifico e 10 nordamericani. Nel collegio
cardinalizio plasmato da Paolo VI si portarono al minimo storico gli elettori di Curia e
al massimo la presenza dei vescovi residenziali, tratti da 30 nazioni diverse,
prefigurando così le condizioni istituzionali per l’elezione di un papa non
italiano.
Nelle
derive postconciliari, specialmente nella congiuntura epocale del Sessantotto, il
riformismo montiniano apparve bruscamente messo in questione da livelli di richieste più
incisive, come quelle provenienti dalla Chiesa olandese. La critica antiistituzionale si
accompagnava alla crisi dell’istituzione ecclesiastica, con l’abbandono del
ministero da parte di numerosi sacerdoti e religiosi, il crollo dell’associazionismo
laicale, una polarizzazione crescente all’interno della Chiesa. Secondo Antonio
Acerbi – che ha distinto in differenti periodi il pontificato, assumendo la
discriminante del Sessantotto – «il crescere tumultuoso delle novità, non filtrato
da una riflessione adeguata, l’urto fragoroso di mentalità inconciliabili, la spinta
delle passioni collettive, che segnavano il momento storico, urtavano la sensibilità del
papa, cui erano psicologicamente estranei i nuovi fermenti sociali, il clima culturale
dell’ora, le tensioni interne alla Chiesa. Riflessivo, circospetto, sensibile alle
sfumature del pensiero, cauto nelle decisioni, il papa concepiva il dialogo in
un’atmosfera di calma nobiltà intellettuale, sorretto da un incontro anzitutto
spirituale. Di qui il tono accorato, deluso, ansioso di molte sue parole» (A. Acerbi, Il
pontificato di Paolo VI, in Storia dei Papi, a cura di Martin Greschat e Elio Guerriero,
Cinisello Balsamo 1994, p. 935).
|
«"Papa del dubbio" egli lo era effettivamente di fronte a una contestazione che arrivava a colpire alcune sue convinzioni irrinunciabili, tra le quali quella di salvaguardare ad ogni costo il potere monarchico totale, come era esistito prima di lui e come egli sentiva di dover preservare, dopo di lui, a disposizione dei successori» (J. Grootaers). Ma questa persuasione fondamentale non era incompatibile con la consapevolezza della complessità dei nuovi problemi che fronteggiano la Chiesa nella nuova età dei diritti soggettivi e della democratizzazione. In un appunto personale, steso nel corso del 1975, egli stesso cercò di autodefinirsi: «Il mio stato d’animo? Amleto? Don Chisciotte? Sinistra? Destra?… Non mi sento indovinato» (cfr. Pasquale Macchi, Discorso di commemorazione, Notiziario dell’Istituto Paolo VI, 1, p. 50). Forse egli suggeriva, nelle sue lente istruttorie, un modello di magistero che non poteva rifugiarsi senz’altro nella definizione e riproduzione delle certezze tradizionali in vista di una pretesa unificatrice e deduttivistica della inedita complessità della società moderna e della stessa Chiesa. In questo, la sua naturale esitazione psicologica poteva apparire piuttosto il riflesso di una problematicità coerente con la cultura moderna, di cui egli era figlio non meno di quanto lo fosse del dogma. |
Essa reagiva in lui mettendo in tensione il suo essere Pietro e il suo essere Paolo, il
suo compito di conservare il passato e l’altro, di cercare quel nuovo, destinato a
formare la tradizione di domani.
E
tuttavia, il Papa del dialogo manifestava la sua convinzione di fare quadrato intorno alle
prerogative dogmatiche della funzione petrina della Chiesa: un Pietro che si inginocchiava
sul Santo Sepolcro a Gerusalemme o sulla riva del Lago di Tiberiade, nel primo grande
viaggio del 1964 in Terra Santa, un Pietro che si prostrava a baciare i piedi del
metropolita Melitone, inviato dal patriarca Atenagora alla celebrazione vaticana del 1975
per il primo decennale dell’abolizione delle scomuniche tra Roma e Costantinopoli,
era lo stesso che nella visita al Consiglio ecumenico delle Chiese a Ginevra nel 1969 non
esitava ad affermare: «Il nostro nome è Pietro». Il caso suscitato nel 1970 dal libro
di Hans Küng Infallibile? Una domanda, diede l’occasione per un intervento severo
della Congregazione per la dottrina della fede nella riaffermazione della dottrina
primaziale del 1870. Montini era in prima linea nel rivendicare «il potere pieno,
supremo, universale del Romano Pontefice, potere che non può essere ridotto a circostanze
particolari» (Discorso alla segreteria del sinodo dei vescovi, 14 ottobre 1974).
| Una tale premura si manifestò senza equivoci nella questione della riforma in senso collegiale del governo pontificio. Già durante il Concilio le riserve papali, manifestate mediante la Nota praevia per controbilanciare le aperture collegialiste votate dall’assemblea, avevano rivelato la volontà del Papa di ridurre la collegialità ad una mistica "collegialità affettiva", cioè ad una forma subalterna di assistenza ad una monarchia pontificia che non sopportava per il momento alcuna restrizione. La stessa istituzione del sinodo dei vescovi, a Concilio ancora aperto, il 15 settembre 1965, comportava il limite di una sua soggezione "diretta e immediata" all’autorità pontificia e di una sua funzione normalmente solo consultiva. |  |
Lo stesso senso dell’inderogabilità del potere pontificio accompagnava la
politica ecumenica di Paolo VI, anche se ciò non gli impediva di recepire la formula
delle "Chiese sorelle" con l’Oriente ortodosso e consentiva alla
Commissione mista anglicana-cattolica di emanare nel 1976 una Dichiarazione
sull’Autorità nella Chiesa che riformulava in termini patristici le condizioni per
una accettazione del primato papale da parte di Canterbury. Tuttavia il punto chiave della
ristrutturazione collegiale del primato appariva così precluso da motivare la presa di
posizione del primate del Belgio cardinale Suenens il quale, in un’intervista
clamorosa del 1969, osservò che il sinodo in quella versione era «una caricatura della
collegialità», una critica ardita, che rilevava la scomposizione del blocco progressista
protagonista delle riforme del Concilio.
Ma
quell’alleanza aveva già rivelato la sua fragilità con la crisi seguita alla
pubblicazione dell’enciclica Humanae vitae nel 1968. Due anni più tardi emergeva con
virulenza una contestazione antipapale di segno conservatore, interpretata dal vescovo
integralista Marcel Lefebvre. Non potendo accettare di compromettere l’autorità e la
ricezione integrale del Concilio, che Lefebvre continuava a ritenere
"scismatico", il Papa decise nel luglio 1976 di dichiarare sospeso a divinis il
vescovo ribelle di Écône, ben consapevole che i burattinai del caso si occultavano
all’interno della Curia romana.
Era un
epilogo paradossale dell’intera strategia compromissoria con la quale Montini aveva
cercato di contenere le esplosioni postconciliari in un alveo finalmente romano.
L’Anno Santo della Riconciliazione, proclamato nel 1975, vide il suo estremo
tentativo di rilanciare lo spirito del Concilio per riprendere il controllo di un
anticonciliarismo disordinato, che Roma riusciva a governare non senza fatica. Si potevano
percepire già da allora non solo le crepe sulla solidarietà tra le correnti riformiste
che avevano "fatto" il Concilio, scindendosi poi in una moderata e
nell’altra radicale, ma altresì la fragilità stessa dell’ipotesi riformista
fondata sul compromesso istituzionale, in una cultura cattolica che sembrava capace non
d’altro che di sublimare la forma della societas christiana, affrancandola
dall’antimodernismo e dai residui illiberali della supremazia teocratica sulla
società moderna. Non a caso fu precisamente il teorico dell’adattamento democratico
di quella "società cristiana", Jacques Maritain, ad assumere nel postconcilio,
con il Paysan de la Garonne, l’inquietudine diffusa per la precipitazione della crisi
della Chiesa in quel versante del dialogo con la modernità nel quale il Vaticano II aveva
compiuto uno dei suoi sforzi inventivi più significativi.
|
Non v’è dubbio che il pontificato di Paolo VI ha registrato sviluppi e
accelerazioni anche teoriche precisamente in questo versante politico. Nel discorso alle
Nazioni Unite a New York, il 4 ottobre 1965, egli si presentò alle nazioni come portavoce
non di un potere religioso ma di una Chiesa «esperta in umanità», disposta ad offrire
un patrimonio etico bimillenario per aiutare la ricerca della pace, della giustizia e
della sicurezza nel mondo. Nel viaggio a Bombay, nel 1964, egli aveva messo l’accento
sul servizio ai popoli sottosviluppati, a favore dei quali aveva proposto ai governi,
inascoltato, di devolvere una minima quota dei bilanci militari. Negli anni seguenti il
Papa raggiunse in altri viaggi Bogotà, Kampala e Manila, con tappa, nel 1970, a Hong
Kong, da dove egli lanciò un invito al dialogo alla Cina di Mao Zedong. Sulla scena internazionale, Paolo VI rielaborò con significativi sviluppi la linea della «neutralità attiva» proposta da Giovanni XXIII. |
Le posizioni pontificie, critiche nei confronti della prosecuzione della guerra
americana in Vietnam, furono presentate senza reticenze dal Papa in udienze drammatiche ai
presidenti americani Johnson e Nixon. Le iniziative sul piano diplomatico e su quello
dell’opinione pubblica per far cessare quella guerra, e comunque separare la Chiesa
cattolica dagli interessi strategici dominanti nel Sudest asiatico, non sortirono alcun
esito immediato. Il tentativo compiuto dal Papa nel 1965 di impedire un bombardamento
americano su installazioni nucleari cinesi non fu conosciuto che più tardi: ma
quell’impotenza politica del papato in Occidente era la testimonianza di una funzione
critica adottata per preservare l’universalità della Chiesa nel suo servizio a tutti
gli uomini e a tutti i popoli, e in primo luogo a quelli vittime dell’ingiustizia.
Papa
"politico", Montini nutriva una fede indiscussa negli strumenti della ragion
pratica. Nella sua azione per la pace nel Vietnam egli preferiva indubitabilmente gli
strumenti della diplomazia a quelli della profezia, secondo un’apostrofe rivoltagli
dal cardinale Lercaro. Con l’Ostpolitik, interpretata da monsignor Agostino Casaroli,
Paolo VI riuscirà a strappare ai regimi comunisti dell’Europa centroorientale una
serie di modus vivendi che, al di là dei relativi vantaggi immediati, comportavano almeno
il riconoscimento formale da parte comunista che anche le religioni hanno diritto a degli
statuti pubblici. Malgrado le opposizioni di alcuni settori cattolici, timorosi che gli
avvicinamenti di ordine pratico potessero trascinare cedimenti ideologici, il Papa
proseguì senza incertezze la linea del dialogo. Egli obbligò il cardinale Mindszenty ad
abbandonare il suo esilio volontario nell’ambasciata americana a Budapest, ove si era
rifugiato nei giorni della rivolta antisovietica del 1956, e gli offrì ospitalità a
Roma. Egualmente accettò di trasferire monsignor Beran dal confino comunista in
Cecoslovacchia all’esilio a Roma, sacrificandolo, cardinale, sull’altare
dell’intesa con Praga per la normalizzazione della vita della Chiesa in quella
Repubblica.
L’Ostpolitik
di Paolo VI raggiunse sicuramente l’apice con la decisione di far partecipare la
Santa Sede come membro a parte intera della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione
in Europa.
| L’Atto finale del processo di Helsinki, che includeva le richieste della Santa Sede relativamente ai diritti di libertà di coscienza, di religione e di culto negli Stati membri, inclusi dunque l’Urss e i Paesi a regime comunista europei, venne sottoscritto a nome del Papa da Casaroli il 1° agosto 1975: non era solo l’esito positivo di una linea che aveva saputo affrancarsi dalla dottrina della "crociata" e della contrapposizione, ma anche l’avvio di una dinamica di lungo periodo, che avrebbe insinuato in sistemi ideologici chiusi come quello sovietico elementi di confronto, di contraddizione e di diritto suscettibili di conseguenze esplosive sul medio e lungo periodo: |  |
una prospettiva infatti che, aperta da Paolo VI non senza difficoltà interne ed
elementi di incertezza inizialmente legittimi, sarebbe stata portata a maturazione da
Giovanni Paolo II dieci anni dopo.
Seguendo
l’adesione manifestata nel 1971 al Trattato di non proliferazione delle armi
nucleari, papa Montini suggerì alle Nazioni Unite, col documento La Santa Sede e il
disarmo nel 1977 una "strategia del disarmo" che includeva l’accesso ai
finanziamenti internazionali per Paesi che riducessero le loro spese militari a scopi
sociali. Non solo l’impegno per la pace internazionale ma anche l’intera
dottrina sociale della Chiesa trovò in Paolo VI un convinto fautore, contro ipotesi di
abbandono ventilate da teologi radicali. Con l’enciclica Populorum progressio (26
marzo 1967) egli riabilitò il principio biblico della destinazione universale dei beni,
distanziandosi da un’interpretazione liberista e individualista della proprietà
privata. Le vie dell’insurrezione rivoluzionaria non incontrarono il favore del Papa,
che le considerava fomiti di «nuove ingiustizie, nuovi squilibri». Tuttavia egli
ammetteva, seguendo san Tommaso, l’eccezione di una tirannia "evidente e
prolungata". In generale egli sosteneva la via di «trasformazioni audaci, di riforme
urgenti» per la soluzione dei problemi del sottosviluppo globale, rivendicando il
principio che «il superfluo dei Paesi ricchi deve servire ai Paesi poveri» anche per
evitare che «la collera dei poveri si abbatta sull’avarizia dei ricchi».
Un’applicazione significativa della prudenza pontificia circa i metodi rivoluzionari
si poteva cogliere nell’attendismo mantenuto dalla Santa Sede verso i movimenti di
liberazione delle colonie portoghesi in Africa: l’udienza papale del 1° luglio 1970
ai leader di tali movimenti fu raffreddata per non turbare i rapporti col Portogallo,
benché fosse nota la riluttanza di Montini verso il regime di Salazar e la sua volontà
di sbarazzarsi dell’ipoteca del vecchio protettorato civile della Chiesa, e in
particolare della nomina dei vescovi.
Negli
ultimi anni del pontificato la crisi della ipotesi di società cristiana, cui Montini era
legato, fu percepita da lui con sufficiente preveggenza per imporgli un mutamento di
paradigma. L’enciclica Octogesima adveniens (14 maggio 1971) riconobbe la perdita di
rilevanza storica e di praticabilità del tradizionale apparato teorico della Chiesa in
materia politica e sociale fino a dichiarare la rinuncia alla pretesa di fornire risposte
ultimative e onnivalenti ai problemi sociali. Ebbe enormi ripercussioni l’ammissione
che «di fronte a situazioni così variate, ci è difficile pronunciare una parola unica,
come proporre una soluzione che abbia valore universale. Tale non è la nostra ambizione e
nemmeno la nostra missione. Tocca alle comunità cristiane analizzare con obiettività la
situazione propria del loro Paese, di chiarire alla luce delle parole inalterabili del
Vangelo, di attingere principi di riflessione, norme di giudizio e direttive di azione
nell’insegnamento sociale della Chiesa quale si è elaborato nel corso della storia
[…]. A queste comunità cristiane tocca discernere, con l’aiuto dello Spirito
Santo, in comunione con i vescovi responsabili, in dialogo con gli altri fratelli
cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà, le opzioni e gli impegni che conviene
assumere per operare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche che risultano
necessarie in molti casi con urgenza». Questa enciclica portò anche al superamento delle
formule integraliste della presenza politica dei cristiani, sottolineando che «bisogna
riconoscere una legittima varietà di opzioni possibili» e che «una medesima fede
cristiana può condurre a impegni differenti».
|
Alle enunciazioni teoriche corrispondeva in effetti un processo di secolarizzazione più precipitoso e devastante del previsto, che frantumava giorno per giorno la prospettiva di una "società cristiana". Tra la sorpresa dei cattolici, poco avvertiti del divenire della storia (G. Martina), il referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio in Italia il 12 maggio 1974 mostrò che il 59,1 per cento degli italiani era favorevole al mantenimento della legge, il 40,9 per cento contrario. Come avrebbe confermato l’esito del referendum sulla legge intorno all’aborto nel 1981, la cristianità in Italia era al tramonto, benché la gerarchia, incoraggiata dal Papa, continuasse la sua battaglia con reiterati richiami al classico senso cristiano. Lo stesso Paolo VI si impegnò in questi tentativi di arginamento, con i suoi interventi sulle Acli, che avevano deciso di assumere "la scelta di campo socialista", e sulle candidature di personalità cattoliche nelle liste del Partito comunista italiano. Se in questi tentativi appariva la preoccupazione del Papa per il funzionamento degli strumenti tradizionali di presenza sociale della Chiesa, la visione di insieme degli accordi, dei concordati e di altri strumenti sotto il pontificato di Paolo VI indica facilmente che la Santa Sede riconosceva ufficialmente la fine della cristianità, con tutti i suoi aspetti ambivalenti, accettando la rinuncia ai suoi antichi privilegi, il principio cardinale della libertà religiosa, l’esaurimento della "religione cattolica come religione di Stato" anche in Paesi cattolici come la Spagna, il Portogallo, l’Italia. |
L’esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi, frutto del sinodo del 1974, rappresentava l’esito di
una ricerca all’interno della crisi delle forme della cristianità. Il Papa abbozzava
nel documento una figura di Chiesa affrancata dalle premure e dai vincoli del potere
politico, impegnata nell’inerme annuncio dell’Evangelo a tutte le genti, come
estremo e unico suo compito «alla vigilia di un nuovo secolo, la vigilia anche del terzo
millennio del cristianesimo». Come già nel suo viaggio in Uganda, durante il quale egli
aveva profetizzato lo sviluppo di un cristianesimo "autenticamente africano",
così egli prevedeva, verso la fine del pontificato, una pluralità di forme cristiane
rimpollate al di là della forma occidentale ormai esaurita come forma universale.
Fino
alla fine Paolo VI incontrò le difficoltà di strati influenti del sistema ecclesiastico
a seguirlo su questo percorso. Gli stessi mezzi e i linguaggi della diplomazia gli si
spensero in mano quando, nella Lettera alle brigate rosse del 21 aprile 1978, egli chiese
loro di liberare «senza condizioni» il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro
da loro sequestrato.
L’analisi
di questo pontificato sembra autorizzare la conclusione indicata dallo storico Roger
Aubert, secondo il quale «se Paolo VI non è riuscito a realizzare pienamente
l’ideale che si era prefisso, di una duplice fedeltà alla Tradizione e agli appelli
del mondo moderno, […] nondimeno egli ha trasformato la Chiesa in profondità». Alla
sua morte, avvenuta il 6 agosto 1978, solo il libro dei Vangeli fu disposto, aperto, sul
feretro ai funerali in piazza San Pietro: impressionante semplicità pubblica di un sommo
potere religioso, circondato nella sua povertà esteriore dalle rappresentanze di quasi
tutti gli Stati affluite per i funerali. Forse l’estremo messaggio di un Papa che
volle comunque rinnovare l’immagine del papato.