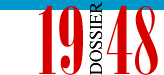 |
||
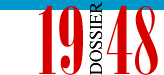 |
||
Il presidente visto da vicino
Emilio Bonomelli, direttore delle Ville Pontificie, ospitò per anni a colazione, nei
giorni festivi, l'onorevole De Gasperi e monsignor Giovanni Battista Montini, godendo
della fiducia e dell'amicizia di entrambi. Ecco un estratto del suo Diario, pubblicato su
Concretezza nel decennale della morte del presidente.
18
aprile 1948 - De Gasperi aveva chiuso nella sera del venerdì, a piazza del Popolo, la
serie trionfale dei suoi comizi, tenuti nel corso di due mesi in ogni parte d'Italia, e
che già nel successo personale da lui conseguito avevano fatto ben presagire sull'esito
delle elezioni.
La
mattina del 18, di buon'ora, dopo aver votato e ascoltato come ogni domenica la messa a
San Pietro, raggiunse la villa, dove si trattenne, senza ricevere visite, fino al
pomeriggio del martedì. Nella serata e nella notte del lunedì le trasmissioni della
radio e i telefoni del Viminale venivano via via confermando per la Democrazia cristiana
una vittoria che superava ogni più rosea previsione.
L'indomani
nella tarda mattinata, con un sole sfolgorante, facemmo una lunga passeggiata sulla via
dei Laghi. Ricordo perfettamente che già da quel momento, pur davanti a un successo che
gli dava, almeno per la Camera dei deputati, la maggioranza assoluta, De Gasperi
manifestò il proposito di non rinunciare alla collaborazione degli altri partiti
democratici, verso i quali peraltro anche durante la campagna elettorale aveva dimostrato
una incondizionata solidarietà. E se una preoccupazione egli ebbe allora, fu che una
parte dei suoi, specie fra i giovani, fosse tentata di praticare una politica, come ora si
direbbe, integralista.
L'imponenza
dei suffragi ottenuti dal partito, assiso ormai stabilmente alla direzione della cosa
pubblica, riproponeva più acuto che mai all'attenzione di De Gasperi il problema dei
rapporti con la Chiesa al cui magistero egli, cattolico tutto d'un pezzo, non poteva non
inchinarsi incondizionatamente per quanto ha tratto alla difesa dei valori religiosi; non
però per ciò che riguardava i modi e i tempi dell'azione politica. E se egli rivendicava
in questo la propria autonomia, era prima di tutto nell'interesse della Chiesa stessa che,
col pericolo sempre presente di un risveglio del vecchio anticlericalismo, non doveva
essere coinvolta nei rischi e nelle insidie della politica. Di questa, diceva, i
responsabili siamo noi, pronti anche a pagare di persona. Non c'era ragione, almeno
teoricamente, sosteneva, che per i cattolici italiani si usasse un metro diverso che per i
cattolici belgi o francesi o tedeschi.
La
coesistenza nella stessa città dei due poteri ne rendeva necessariamente più delicati i
rapporti. "Per questo" lo sentii dire "ci si doveva comportare come se
migliaia di chilometri, e non quel breve spazio, separassero il Vaticano dal
Viminale".
D'altronde
anche Pio XII da parte sua si è ognora dimostrato rispettoso di tale autonomia, pur non
nascondendo talvolta il suo disappunto per le incertezze e le deficienze dell'azione
governativa specie nei confronti della minaccia comunista, fino a quando, nel 1947, i
socialcomunisti vennero estromessi dal governo. Non ci fu mai nessun intervento diretto
del Vaticano nella politica italiana; lo stesso Osservatore Romano si limitava a
pubblicare, nelle vigilie elettorali, gli appelli dell'episcopato all'unità dei
cattolici.
Fu
sempre osservata da Pio XII nei confronti personali di De Gasperi una norma di grande
riserbo e discrezione. Costantemente ricambiata dall'uomo di Stato che si sentiva, prima
di ogni altra cosa, figlio devoto della Chiesa. Mai egli avrebbe tollerato una espressione
meno che riguardosa verso il Pontefice anche se poteva qualche volta non condividerne
vedute e apprezzamenti politici. Mi si consenta accennare a questo proposito a un fatto
quanto mai significativo. De Gasperi ha potuto per oltre quindici anni, durante il
pontificato di Pio XII, frequentare a Castel Gandolfo l'abitazione di un funzionario
vaticano suo amico personale, sul suolo stesso della residenza, anche nel corso dei lunghi
soggiorni estivi del Papa (che ne era sicuramente a conoscenza) senza che Pio XII se ne
adontasse. E si può aggiungere, fatto anche più singolare, senza che tutto ciò desse
luogo a interpretazioni malevole da parte di chicchessia. Cosa che, bisogna convenirne,
avrebbe pur trovato qualche apparente giustificazione.
De
Gasperi venne ricevuto due sole volte dal Pontefice e sempre in visite ufficiali, una
prima volta il 31 luglio 1946 quando, presidente del Consiglio, accompagnò in Vaticano
Enrico De Nicola appena eletto capo dello Stato, la seconda l'11 febbraio del 1949, nel
ventennale della Conciliazione. Si possono ricordare, del saluto rivolto da Pio XII a De
Gasperi in quella circostanza, le parole particolarmente calorose che ne riconoscevano la
dottrina, le insigni qualità di governo e la integrità della vita. All'infuori di queste
visite ufficiali De Gasperi non aveva mai sollecitato udienza dal Pontefice, nemmeno
quando, dopo la liberazione, quasi tutti gli uomini politici più in vista dei vari
partiti, all'infuori di Togliatti, varcarono le soglie del Vaticano. Vale anche la pena di
accennare a un altro fugace incontro, se così si può chiamare, fra Pio XII e il
presidente quando nel 1950, nell'Anno Santo, ricevendo a San Pietro fra gli altri un
pellegrinaggio trentino, il Pontefice, portato in sedia gestatoria, poté riconoscere
confusa nella folla la figura di De Gasperi, e volgendosi ostentatamente verso di lui lo
salutò e benedisse con larghi gesti della mano, ripetutamente.
Si fa
un gran parlare in questi giorni di un'udienza non concessa nel 1952 e che era stata
richiesta per apprezzabili ragioni familiari. Conviene rilevare però, a questo proposito,
che da anni Pio XII aveva adottato la risoluzione di non ricevere nessun uomo politico
italiano.
Ritornando
per un momento a quei nostri discorsi nella passeggiata sulla via dei Laghi, in quella che
fu la più radiosa giornata dello scudo crociato, mi sovviene di un singolare accenno
affiorato allora nei pensieri dell'amico scomparso. De Gasperi era ben convinto in quel
tempo della necessità di mantenere a ogni costo l'unità dei cattolici, fino a che
permaneva l'incombente minaccia di un potente Partito comunista e non si fossero
consolidate in Italia le ancora deboli istituzioni democratiche. Ma il travolgente
successo di quel 18 aprile gli poté far credere che non fosse lontano il giorno, che egli
vagheggiava in cuor suo, in cui i cattolici potessero sul terreno politico separare
pacificamente le loro forze - come era stato già, nel Belgio - fra cattolici
conservatori, e un movimento più ardito di azione sociale che egli chiamava laburismo
cattolico.